Finanziare il futuro: territori tra equità e autonomia
La finanze locale al bivio: dopo anni di tagli e diseguaglianze, i Comuni tornano protagonisti grazie al PNRR. Ma senza nuove risorse stabili e una reale perequazione, il rischio è di perdere l’occasione di costruire un’Italia più giusta e coesa.

La storia recente della finanza locale in Italia è segnata da una progressiva sottrazione di risorse. Nel giro di pochi decenni i trasferimenti statali agli enti locali sono stati sistematicamente ridotti, comprimendo gli spazi di manovra dei comuni e lasciandoli più soli di fronte a compiti sempre più vasti e complessi. Come dice la Banca d’Italia, tra il 2011 e il 2018 i comuni hanno contribuito al risanamento della finanza pubblica per oltre 12 miliardi di euro, pari a circa un quarto della loro spesa corrente. Il contributo più elevato rispetto a qualunque altro livello di amministrazione. Tagli dolorosi, concentrati soprattutto sui trasferimenti erariali, che hanno colpito in misura maggiore i comuni più grandi e quelli del Mezzogiorno. Non a caso la prima voce sacrificata è stata la spesa per gli investimenti: più facile rinviare un’opera pubblica che ridurre i servizi essenziali, naturalmente. Pagando tuttavia un prezzo altissimo in termini di opportunità di sviluppo, cura del territorio, connessioni materiali e immateriali. Solo negli ultimi anni, con l’allentamento dei vincoli di bilancio e grazie alla stagione del PNRR, si è riaperta una parentesi positiva. Ma il dato storico resta: i comuni italiani hanno visto restringersi drasticamente la quota di finanziamento ordinario, con conseguenze spesso drammatiche sulla vita delle comunità, mentre la mancanza di investimenti ha di fatto bloccato il progresso delle nostre realtà. Quello delle risorse è un tema, dunque, che oggi non possiamo più ignorare. Tantomeno può farlo un’associazione come ALI, che ha tra i suoi riferimenti fondativi una figura come quella di Giacomo Matteotti e la centralità della salute delle finanze locali come condizione indispensabile di sviluppo e benessere. Da qui la scelta di dedicare questo secondo numero di Eutopica al tema cruciale della finanza locale, con una serie di autorevoli contributi, e con il coordinamento del professor Francesco Porcelli.
Lo scenario che emerge gettando uno sguardo attento allo stato delle finanze locali è di una diffusa ed estrema criticità, con fortissime diseguaglianze. Sul terreno dell’agibilità finanziaria degli enti locali si è innestato il percorso, ancora incompiuto, della perequazione. L’articolo 119 della Costituzione ci dice che i territori devono poter contare su risorse adeguate e comparabili per garantire servizi uniformi ai cittadini. Ma la realtà è che siamo ancora lontani dall’obiettivo. Nonostante nel 2025 la perequazione copra il 60% del fabbisogno standard, il Paese resta spaccato. Da una parte ci sono comuni in carenza strutturale, costretti a spremere al massimo le leve fiscali locali: addizionale IRPEF allo 0,8%, IMU al 10,6 per mille, margini residui pressoché azzerati. Dall’altra, comuni con basi imponibili ricche che dispongono di surplus di risorse, con aliquote più basse e spazi fiscali inutilizzati. È un’Italia che procede a due velocità, con cittadini che in alcuni territori pagano di più per ricevere di meno, mentre altrove avviene l’opposto. Non è questa l’idea di eguaglianza sostanziale che la Costituzione ci chiede di perseguire.
Al divario di risorse si somma il problema della riscossione. In molti territori, soprattutto al Sud, anche fissare le aliquote al massimo non garantisce entrate adeguate: il tax gap resta elevato, e i comuni più poveri sono spesso quelli che meno riescono a riscuotere. Da qui un circolo vizioso che mina la sostenibilità dei bilanci locali. Ma ci sono anche esperienze che mostrano come sia possibile invertire la rotta. Napoli, ad esempio, ha avviato un programma di recupero dell’evasione che in poco più di un anno ha portato a incassare oltre 200 milioni di euro, con l’obiettivo ambizioso di un miliardo in dieci anni. Roma ha intrapreso un cammino analogo: abbiamo lavorato tre anni per ricostruire banche dati frammentate, incrociare anagrafe e catasto, scovare oltre 360 mila utenze “fantasma”. Questo impegno ci ha consentito di recuperare più di 50 milioni di euro, aumentare del 53% gli incassi della TARI rispetto al 2021 e, fatto inedito, abbassare le tariffe a cittadini e imprese. Anche sull’IMU, nonostante una riduzione della base imponibile dovuta a un contenzioso, Roma ha incassato più del 2020 grazie a un lavoro di accertamento più incisivo. Sono segnali che ci dicono che la strada è quella giusta: non aumentare le tasse, ma combattere l’evasione e rendere la riscossione più equa ed efficace.
C’è però un altro tema che non possiamo eludere: i comuni devono poter esercitare davvero l’autonomia fiscale prevista dalla Costituzione. Significa non solo avere la possibilità di portare le aliquote principali ai livelli massimi, ma anche di ampliare il ventaglio delle entrate, intervenendo su quei cosiddetti “tributi minori” che troppo a lungo sono stati trascurati. Parliamo di tariffe e corrispettivi per i servizi a domanda individuale, che possono essere calibrati in modo più equo e più certo nella riscossione; dell’imposta di soggiorno, che in molte città potrebbe rappresentare una risorsa ben più significativa se gestita con regole uniformi e controlli efficaci; delle addizionali aeroportuali e portuali, già introdotte in alcuni grandi scali come Roma, Napoli o Venezia; fino al canone unico e ad altre entrate legate al turismo, alla cultura, alla mobilità urbana. È evidente che non tutte queste leve abbiano lo stesso peso, ma nel complesso contribuiscono a diversificare e rafforzare i bilanci comunali, riducendo la dipendenza da poche imposte e aumentando la corrispondenza tra servizi e fonti di finanziamento. In un contesto di margini ormai ridotti sui tributi principali, i comuni italiani ̶ soprattutto dopo la pandemia ̶ hanno infatti iniziato a valorizzare al massimo le voci tributarie ed extratributarie tradizionalmente considerate “minori” o “residuali”, una definizione che oggi appare eufemistica, poiché il loro gettito è passato da 9,4 miliardi di euro nel 2016 a 11,1 miliardi nel 2023. Rientrano in questa categoria, in particolare, l’imposta di soggiorno, il canone unico patrimoniale, i proventi da concessioni su beni e i proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità.
In parallelo, resta cruciale la questione delle compartecipazioni. Affidare ai comuni una quota del gettito di grandi tributi nazionali, come l’IVA o l’IRPEF, può essere una strada utile per garantire risorse stabili e coerenti con l’andamento dell’economia. Ma non basta distribuire percentuali: serve un quadro chiaro, trasparente e stabile, che consenta agli enti locali di programmare con certezza le proprie entrate negli anni. Altrimenti, le compartecipazioni rischiano di essere percepite come occasionali e frammentarie, incapaci di dare quella solidità di prospettiva di cui i bilanci comunali hanno bisogno. Su questo tema è importante costruire un dibattito serio riguardo alla nuova delega fiscale, e un percorso condiviso tra regioni e comuni, in modo da favorire una collaborazione proficua e non uno scontro tra livelli di governo.
C’è poi la questione degli investimenti. Per anni sono stati la vittima sacrificale dei tagli e dei vincoli, ma con il PNRR i comuni hanno ritrovato un protagonismo straordinario. Nel 2023 la spesa in conto capitale è salita a 16,3 miliardi, con un aumento del 40% sull’anno precedente. Un balzo certificato dalla Corte dei conti, che fotografa un cambiamento epocale: comuni che tornano a fare quello che sanno fare meglio, cioè mettere a terra progetti, trasformare risorse in opere e servizi. Grazie alla clausola del 40% al Sud, il divario territoriale negli investimenti si è quasi colmato: 287 euro pro capite al Sud contro 289 al Nord. È la dimostrazione che, se messi nelle condizioni, anche i territori più fragili possono esprimere capacità progettuale e dare risposte concrete ai cittadini. Scuole, rigenerazione urbana, infrastrutture idriche e digitali, impianti sportivi: è qui che si costruisce una parte importante del futuro del Paese.
Ora, però, siamo di fronte a un bivio. Con la scadenza del PNRR nel 2026, cosa succederà alla capacità di investimento dei comuni? Sarebbe un errore imperdonabile fermarsi, lasciando che la macchina messa in moto rallenti di nuovo. I comuni hanno dimostrato di saper spendere bene e velocemente, di essere il livello di governo più vicino alle esigenze delle comunità e al tempo stesso il più efficiente nell’attuare progetti. Hanno anche rafforzato le proprie strutture tecniche, investendo in competenze. Non possiamo permettere che questa stagione si esaurisca: occorre programmare fin da ora il dopo-PNRR, garantendo nuove risorse stabili per gli investimenti locali.
Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema della finanza locale è una sfida non solo dal punto di vista sistemico, ma anche immediato, dato che proprio il completamento del federalismo fiscale è una delle riforme abilitante del PNRR e che se non dovesse essere completata, metterebbe a rischio le ultime tranche del Piano di Ripresa e Resilienza.
La verità è che non c’è sfida nazionale che non passi dai comuni e dalle autonomie locali. La crisi climatica si combatte nelle città, con politiche di adattamento e mitigazione che richiedono fondi per la mobilità sostenibile, la forestazione, la resilienza urbana. Le nuove povertà e le emergenze sociali trovano la prima risposta nei servizi di prossimità offerti dai municipi. Sta ai comuni, soprattutto, mettere in campo politiche abitative efficaci. La sicurezza e la qualità della vita dipendono da servizi urbani che costano, ma che sono essenziali per tenere insieme il tessuto sociale. Finanziare il futuro significa allora dare ai comuni strumenti adeguati, completare la perequazione, riformare la fiscalità locale, continuare a investire sugli enti più vicini ai cittadini.
Lo dico non solo come sindaco di Roma, ma come rappresentante di una rete di amministratori che ogni giorno affrontano le difficoltà e le aspettative dei cittadini. In un tempo in cui la politica internazionale appare fragile, i bilanci statali compressi e le tensioni sociali in crescita, non possiamo permettere che la finanza locale torni ad essere la cenerentola della politica economica. Servono risorse, stabilità normativa e fiducia. Perché senza comuni solidi e senza un robusto sistema di autonomie locali non c’è futuro per il Paese. Finanziare i territori significa finanziare la democrazia, l’equità, la crescita. È tempo che l’Europa e lo Stato – a partire dalla nuova legge di bilancio, in cui le indicazioni del Documento Programmatico di Finanza Pubblica e del DPB prevedono un apporto nullo della manovra sul Pil del 2026 e pressoché irrilevante nei due anni successivi e un calo degli investimenti fissi lordi nel prossimo anno inducono a forti preoccupazioni – riconoscano fino in fondo il valore di questa sfida.
Finisci di leggere l'articolo
Inserisci la mail per ricevere un link ai nostri abbonamenti
Oltre all’articolo sbloccato, riceverai la nostra newsletter settimanale principale Eutopica, oltre a occasionali aggiornamenti e offerte. Puoi annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, visita il nostro accordo con l’utente e l’informativa sulla privacy.
Ottieni l'accesso completo a Eutopica Iscriviti
Sei giá iscritto? AccediArticoli Correlati

Bisogni relativi e perequazione negli enti locali: un confronto sui trasferimenti tra Inghilterra e Italia
Di
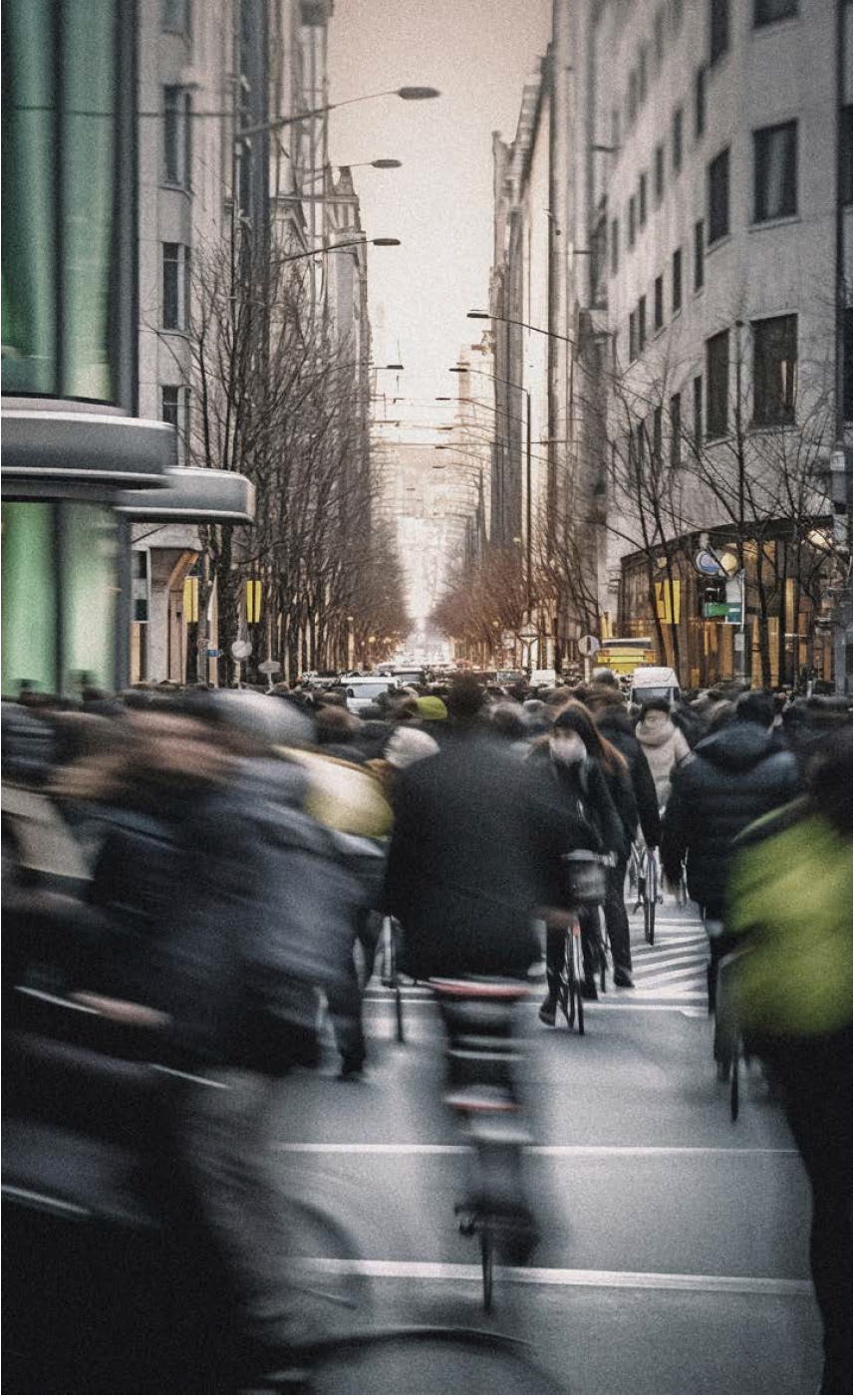
Potenziamento dei servizi sociali comunali e territoriali: un esempio concreto di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
Di
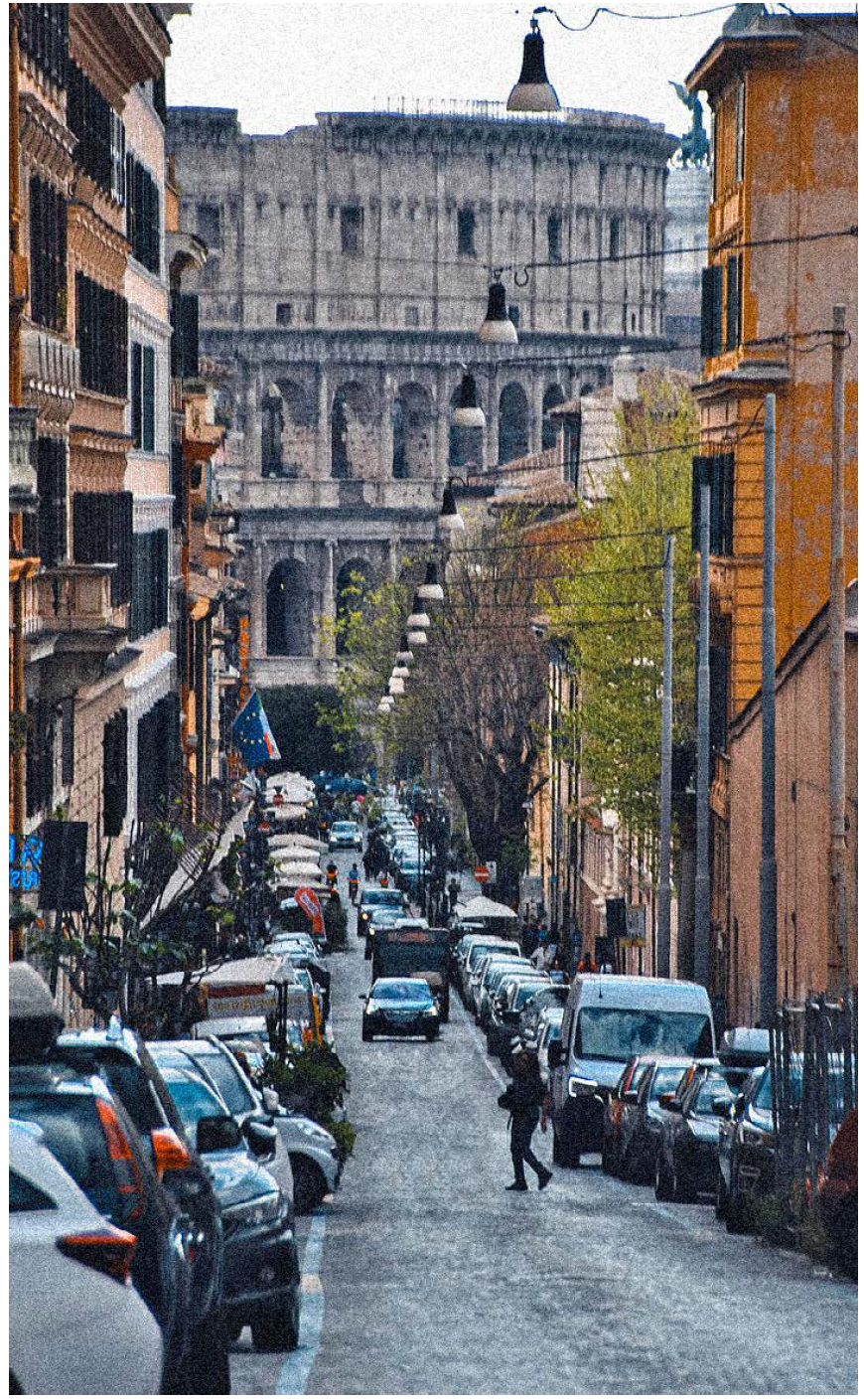
Se non c'è la perequazione ci pensa lo sforzo fiscale
Di

Centralità dei comuni e difficoltà a riscuotere
Di

In che misura i comuni riescono a riscuotere i propri tributi?
Di

Compartecipazione o trasferimenti: è questo il vero problema?
Di
Eutopica è un trimestrale di scienze urbane edito da ALI-Press srl, Società editoriale di ALI - Autonomie locali italiane Eutopica segnata al registro della stampa del Tribunale di Roma al numero 60/2025 con decreto del Presidente di Sezione del 5/6/2025. Il Direttore Responsabile è il Dottor. Valerio Lucciarini De Vincenzi.
SEDE LEGALE
Sede legale Via delle Botteghe Oscure 54 00186